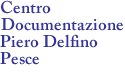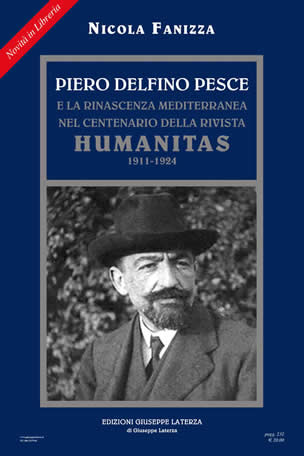Poesia come chance 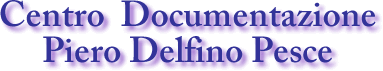
Nel 1902 Piero Delfino Pesce pubblica – presso l’editore Vecchi di Trani – una raccolta di liriche, intitolata Preludio. Il libro contiene cinquantacinque poesie e si articola in quattro parti.
Il senso della sua produzione poetica viene esplicitato dal sonetto Ad rivum, che chiude e, insieme, apre la sua raccolta di versi:
Passa l’acqua così come il mio verso:
gorgogliando discende alla marina;
va senza posa e ognor più si avvicina
a disparir nel liquido universo.
La sua carezza che le roccie affina,
la tenacia che fora il sasso avverso,
tutto, tutto è fatal vada disperso,
il suon, la limpidezza cristallina.
Il verso mio così passa nell’onde
dell’umano parlare vario e selvaggio,
si rompe, si scolora, si confonde;
forse giungendo, inutile messaggio,
dove nessuno ai detti suoi risponde
né fior rallegra il penoso viaggio.
Qui Pesce dice in modo evidente ciò di cui gli scrittori non sempre sono consapevoli: si scrive per essere amati! Il rituale poetico da una parte apre il soggetto alla comunicazione e, dall’altra, non ne garantisce l’esito. L’attività poetica – proprio perché ricade nell’ambito della meravigliosa inanità – è dono e, insieme, chance. Chi è primo ad amare si assume il rischio dell’assenza di reciprocità, è questa la logica del dono.
Sul piano stilistico Pesce si ispira – sulla scorta degli insegnamenti di Armando Perotti – alla poetica carducciana: sceglie con cura le parole in relazione al timbro, «il suon»; e ricerca la musicalità attraverso la rima, «la limpidezza cristallina».
Per quel che riguarda i contenuti, ama il presente anche se non disdegna di rivisitare il passato. Accanto alle poesie in cui sono presenti i temi mistico-romantici dell’anima, del cuore, del sogno e del mistero, vi sono dei componimenti in cui vengono evocate le grandi figure del passato.
Il sonetto La notte è oltremodo interessante, poiché ci fa partecipi del suo pathema d’animo:
Son l’ore della notte quelle in cui
Meno tranquillo il mio spirito posa:
forse scende col sol nei regni bui
per rifornir di fuoco l’operosa
scorta dei sensi; forse quel che fui
durante il giorno con lena affannosa
scruta, e, severo nei giudizi sui,
poche assolve, non loda alcuna cosa.
Alta è la notte, il cuore e il pensiero,
i due atleti terribili che ho meco,
lottano per un briciolo di vero;
e mai non cessa l’orrida tenzone:
questo sangue non ha, quell’altro è cieco,
e l’uno dell’altro non può aver ragione.
A differenza di ciò che accadeva a Prometeo durante le ore notturne, Pesce viene tormentato dai pensieri al primo calar delle tenebre: viene chiamato, infatti, a dire la verità. Una verità che non viene detta agli altri ma se stesso. Tale prassi rientra a pieno titolo nell’ambito dell’estetica dell’esistenza. Per giungere alla verità non è sufficiente il solo discorso tecnico (il criterio dell‘evidenza cartesiana), poiché è necessario anche la mediazione delle passioni.
Il suo tormento è destinato comunque ad aumentare col passare delle ore con l’entrata in scena dei «due atleti» – l’uno al servizio del cuore e l’altro della mente –, che si contendono il controllo della sua anima. Questi ultimi sono i banditori delle opposte vie che dovrebbero consentigli di afferrare almeno un «briciolo di vero». Tuttavia se vero che il sentiero indicato dal cuore è «cieco», è altresì certo che il percorso indicato dal pensiero è senza «sangue». Da qui la difficolta di chi vuol mediare fra le esigenze del materialismo francese (il cuore) e le esigenze dell’idealismo tedesco (il pensiero): le aporie e le ambasce della ragione.
Con la poesia Ida, Pesce fa i conti col fantasma di sua madre.L’incapacità di suo padre di tornare a vivere a dieci anni dalla morte di sua moglie spinge il poeta ad evocare la depressione, che aveva portato sua madre al suicidio e alla successiva disperazione di suo padre: «La buona mamma da un pezzo riposa / sotto il funebre manto / tra un crisantemo bianco ed uno rosa; / il babbo invoca con diuturno pianto / l’anima santa della morta sposa». Da qui l’invito rivolto a suo padre di accontentarsi di quello che la vita gli aveva già dato visto che, a volte, «anche senza sbocciare vizzisce il fiore» e a «non aver terrore dell’età maledetta», poiché occorre comunque vivere malgrado la vita!